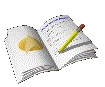|
Il resto del viaggio proseguì non malamente. In piedi sì – anzi: seduto sui predellini del corridoio sull’espresso da Crotone a Milano – e in compagnia di certi ameni profughi dei Balcani, loro però seduti (stravaccati) negli scompartimenti. Di tanto in tanto mi faceva compagnia una giovane profughetta che si divertiva a trasportare un bicchiere d’acqua bucato, dal proprio scompartimento al bagno, dove faceva il pieno, incidentalmente aspergendomi il Corriere della Sera e i pantaloni. All’arrivo in stazione centrale a Milano– nove del mattino, in ritardo di sole tre ore rispetto alla tabella di marcia – seguii il codazzo dei profughi, condividendone idealmente la sorte e la pena (di aver viaggiato con le F.S. obviously). Fui anche fermato dall’imponente cordone di sicurezza (due poliziotti), spediti ad accogliere gli stranieri in Milano. Convinti (dalla giacca e non sicuramente dalla faccia) di avere a che fare non con un profugo, ma con un disgraziato semplice, mi lasciarono andare alla mia ansia dell’incontro con Montanelli, libero e senza neanche tirar fuori i documenti. Arrivai con tre quarti d’ora abbondanti di anticipo, all’appuntamento con Montanelli; nei pressi della sua magione mi diedi da fare inutilmente per capire dove avrei dovuto passare quel tempo. Optai per cornetto e cappuccino (in quest’ordine), e per una visita al vicino supermercato. Fra detersivi e saponette – che trovo reparto molto utile quando si cerca l’ispirazione in un supermercato – cercai inutilmente di recuperare il filo logico delle domande che avevo preparato per Montanelli alla stazione d’Ancona. Trovai solo che era molto tardi e – dopo una ravviata ai capelli (non i miei, quelli altrui che mi aveva lasciato in eredità sulla giacca lo scomodo viaggio), feci in compagnia del portiere la strada che mi separava dall’abitazione dello zio Indro. Al momento di bussare, trovai la porta già scostata e il segretario ad aspettarmi. D’un tratto mi si aprì alla vista una casa signorile, una serie di bastoni da passeggio e un giallo colore dominante. Molta luce. Il borbottare di Montanelli e lo squittio dell’allora ospitessa del maestro, mi arrivavano in lontananza dalla stanza di là, mentre chiacchieravo ancora, e piacevolmente, col gentile e intelligente segretario (ognuno ha i segretari che si merita) che avevo conosciuto solo al telefono. Quando fu il momento… beh: quando fu il mio momento, andai – e deciso – incontro ad un Montanelli più magro della magrezza per com’è generalmente intesa, scomodamente – mi sembrava – installato su una poltrona di velluto verde. Quello che seguì fu un colloquio davvero cordiale, e che mi piacque. Per la prima volta l’emozione mi evitò rossore e balbettii, e anzi diventò sprone ad un colloquio vagamente imbarazzato. Accidenti a quella tesi, che era stata l’occasione per incontrarlo, Montanelli! Avrei voluto buttar via tutto e farmi spiegare tante altre cose, da quel maestro mio. Invece no: è detto che siamo nati per soffrire, e per quel giorno – evidentemente – la sofferenza non era ancora abbastanza. Di tesi dovevo parlare. Fortunatamente mi venne in soccorso più volte lo stesso maestro, deviando abilmente dalla via che con una insicurezza da professionista tracciavo nelle mie domande: finimmo di parlare dei suoi reportages dalla Finlandia nel 1940, e di tante altre amenità che non ricorderò, perché ricorderò di più gli occhi, di quell’uomo. Talmente fissi nelle cose del mondo, nelle cose che hanno visto, che diventano anche un po’ i tuoi, dell’ascoltatore che ha la voglia e l’intelligenza di ascoltare. Un minorenne anziano, Montanelli, con una forza nel cuore che neanche lontanamente ricorda certo ricorrente sconforto del sottoscritto indegno ventitreenne. Qui segue cos’è venuto fuori per la mia tesi. Serbo gelosamente, invece, quello che non riesco a scrivere: quell’emozione che ancora mi rimane, dopo mio primo incontro veramente importante, da qualche parte nello stomaco. lunedì 14 giugno 1999 Piersante Sfredda
|